di Domenico D'Amico
Chi si dispiace per Jean Valjean prima
che incontri il vescovo non può essere una cattiva persona.
(Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei – Episodio 11)
(Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei – Episodio 11)
Lieto fine?
Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano come “positiva” la conclusione del romanzo (dopotutto Jean Valjean muore, seppure consolato dalla presenza della sua pupilla) è la sicurezza economica assicurata a Cosette.
Questo tipo di sicurezza non la si ottiene lavorando. Come dice Jerome K. Jerome, “Per qualche tempo aveva mantenuto se stessa e il bambino con i dodici scellini alla settimana che le fruttavano dodici ore di ingrata fatica giornaliera, spendendo sei scellini per la creaturina e, per quanto la riguardava, tenendo insieme il corpo e l’anima con il poco che le rimaneva. Ma sei scellini alla settimana non ce la fanno a tenere molto uniti il corpo e l’anima.”
D'altro canto, è pur vero che nell'utopia aziendale di M. sur M. gli operai conducono un'esistenza dignitosa, ma si tratta di una situazione estremamente fragile (basta che papà Madeleine scompaia e tutto va a scatafascio). No, niente è meglio di un bel “capitale”, come dice Caderousse nel Conte di Montecristo, e Thénardier è più che d'accordo.
Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano come “positiva” la conclusione del romanzo (dopotutto Jean Valjean muore, seppure consolato dalla presenza della sua pupilla) è la sicurezza economica assicurata a Cosette.
Questo tipo di sicurezza non la si ottiene lavorando. Come dice Jerome K. Jerome, “Per qualche tempo aveva mantenuto se stessa e il bambino con i dodici scellini alla settimana che le fruttavano dodici ore di ingrata fatica giornaliera, spendendo sei scellini per la creaturina e, per quanto la riguardava, tenendo insieme il corpo e l’anima con il poco che le rimaneva. Ma sei scellini alla settimana non ce la fanno a tenere molto uniti il corpo e l’anima.”
D'altro canto, è pur vero che nell'utopia aziendale di M. sur M. gli operai conducono un'esistenza dignitosa, ma si tratta di una situazione estremamente fragile (basta che papà Madeleine scompaia e tutto va a scatafascio). No, niente è meglio di un bel “capitale”, come dice Caderousse nel Conte di Montecristo, e Thénardier è più che d'accordo.
Dopotutto, a parte le ingiustizie subite da Fantine e Valjean, che si possono attribuire direttamente al “sistema”, quali sventure ci dovrebbero commuovere? In un certo senso, il popolo si imbestialisce e autodistrugge, mentre se tutti fossero come Gavroche...
Bella trovata, quella di utilizzare il piano ricattatorio di Thénardier come agnizione santificante per Valjean. Peccato che Thénardier se la cavi totalmente. In Montecristo, almeno, il banchiere Danglar salvava la vita sì, ma dopo una discreta, meritata sofferenza.
Comunque, ai nostri occhi c'è qualcosa di peggio del predatore Thénardier.
I giovanotti che si divertono con le loro grisette, in uno svago sabbatico prima di tornare alle loro promettenti esistenze borghesi, e tra di loro c'è quello che mette incinta Fantine...
La loro ilare indifferenza è agghiacciante.
Letteralmente atroce, poi, la scena del gentiluomo che si indigna per la presenza, in un giardino ordinariamente riservato alla gente perbene, di due bambini di strada (sono i due piccoli Thénardier che Gavroche aiuta senza conoscerne l'identità). Due bambini di pochi anni non suscitano in lui alcuna empatia, nemmeno un'ipocrita benevolenza da benpensante.
Il terzo bambino in scena è suo figlio, la ciambella che ha in mano non gli va più, bene, gli dice il padre, buttala ai cigni.
I piccoli Thénardier riescono a ripescare la ciambella fradicia, sottraendola ai cigni, ma noi sappiamo che il loro destino è segnato.
C'è un triangolo di vecchi morenti,
che esemplificano un percorso storico-ideologico. Da G.,
rivoluzionario doc, al povero erbomane Mabeuf, rivoluzionario per
caso, allo stesso Jean Valjean, non proprio rivoluzionario, questo
no, ma in grado (con la sua “santità”) di letteralmente
decostruire il simbolo dell'ordine e dello status quo
(Javert). Tutti e tre questi vecchi assistono, per così dire, alla
propria dipartita, quasi l'assaporano, senza fretta: “ecco che sto
morendo...”
Cosa distinguerà tuttavia Balzac da Dumas? Il fatto che, non dico il suicidio di Lucien Rubempré, ma la stessa vittoria di Rastignac alla fine di Papà Goriot, non risulteranno consolatori. Rastignac trionfante ci lascerà molta più amarezza che non d'Artagnan, serenamente morto alla fine de Il visconte di Bragelonne.È curioso come una valutazione sociale ed emotiva (amarezza vs consolazione) diventi parametro estetico. Il principio nascosto di questa valutazione è che l'arte “dovrebbe" avere una funzione emancipatoria, altrimenti è industria culturale finalizzata al controllo delle masse.
(Umberto Eco, Il Superuomo di Massa, pag.12)
A mio modestissimo avviso, un pinco pallino qualsiasi potrebbe preferire il “consolatorio” d'Artagnan all'“amaro” Rastignac, e tuttavia mettersi il gilet giallo per andare a farsi massacrare dai poliziotti, mentre un altro pinco pallino potrebbe leggere Joyce e Balzac (e Toni Negri), per poi unirsi a una squadraccia nostalgica del colonialismo razzista britannico, e sfasciare un terminal a Hong Kong.
Hugo sarà stato un borghese avido e politicamente irredimibile, però l'eroina della Comune prese come nom de guerre Enjolras, mica Vautrin.
È un accostamento scorretto, o peggio ingenuo?
Può darsi, penso.
Poi paragono, da tutti i punti di vista (estetici, politici o morali che siano), un personaggio come Gavroche a uno come Dean Moriarty.
Ho detto tutto.


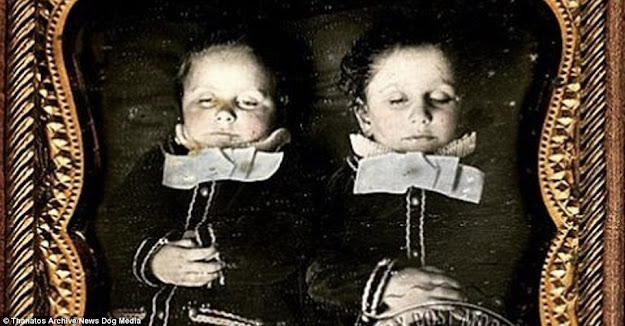


Nessun commento:
Posta un commento